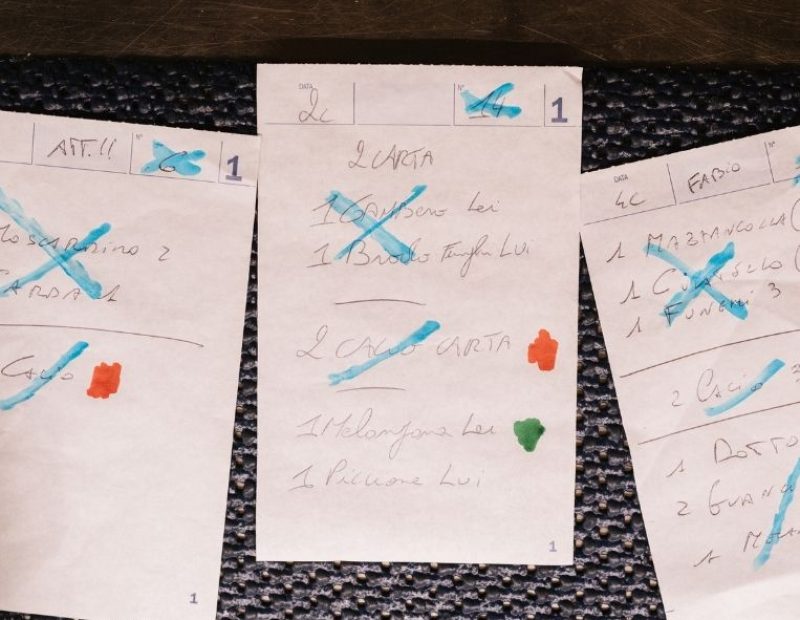C’era una volta, più o meno una trentina di anni fa, la trattoria con il menu recitato a voce. E in questo modello – asse portante della ristorazione italiana – per convenzione comprenderemo anche una buona dose di ristoranti un po’ più “borghesi”, di cucina tradizionale, talvolta a gestione familiare. Locali accoglienti e abbordabili in cui la schiettezza e l’informalità facevano da contorno a una proposta di tradizione e di territorio. Ma, ahimé, locali in cui spesso o spessissimo non c’era menu da leggere e i piatti venivano recitati a voce (a qualcuno ne veniva raccontato uno in più, magari un piatto speciale del giorno, a qualcuno uno in meno, ma di nessuno si conosceva il prezzo). Per questo si spesero crociate a suon di parole, stelle, cappelli e centesimi: un buon ristorante non poteva non offrire un menu stampato da cui poter fare le proprie scelte, con chiarezza e senza rischi. “Viva il diritto al menu, abbasso la dittatura dell’oste”, era lo slogan. E così, anche le trattorie più semplici cominciarono a portare in tavola menu e carta dei vini, come in Francia. Una battaglia vinta. Poi venne la fase delle prime proposte degustazione: chiamate menu anch’esse ma, di fatto, altra cosa: a fianco di scelte di antipasti, primi, secondi e dessert i cugini d’Oltralpe (sempre loro) introdussero una “formula” che permettesse di provare più piatti (ma in porzioni ridotte) a un prezzo conveniente.
Alla metà degli anni Novanta ecco, infine, uno degli chef che cambierà la storia: Ferran Adrià. È sua la teorizzazione del menu come esperienza. Un percorso fatto di snack, tapas (Adrià è catalano ma le tapas qui vanno intese come entrée, antipasti) e piatti. Tanti piccoli assaggi che nel suo ristorante di Cala Montjoi potevano arrivare a essere anche quaranta (!). “Questo tipo di cucina si esprime meglio in forma di menu degustazione”, si legge nel decalogo della cucina del suo ristorante elBulli, che diventerà il manifesto di una nuova tendenza gastronomica capace di influenzare buona parte dei cuochi mondiali, Italia compresa. Ma oggi in che epoca siamo? Prendete gli ingredienti di cui sopra, mescolate senza molta attenzione, aggiungetevi una pandemia e il post MasterChef e scoprirete che l’oste si è trasformato in cuoco, che i piatti non vengono recitati a voce ma che, di fatto, il menu è scomparso di nuovo. “Mano libera”, “Carta bianca”, “A discrezione della cucina”: quelle che erano opzioni offerte ai gourmet incalliti, sono divenute spesso l’opzione unica. Il ristorante fine dining (vogliamo chiamarlo così?) sta cominciando a proporre un solo menu: quello dello chef. Tu chiami al telefono (o prenoti via internet) e puoi, al massimo, dichiarare allergie e intolleranze, ma decidere cosa mangiare quello no, non è più un’opzione. C’è solo un menu e non è neanche dato sapere da quali piatti sia composto, al massimo quanti. E non si tratta – come alcuni sostengono – di una questione di ottimizzazione dei costi, non stiamo parlando del menu del giorno di una trattoria, la cui convenienza peraltro è condivisa con il cliente. Così, più che commensali si diventa spettatori (come ha recentemente ben scritto anche il collega Paolo De Cristofaro sul blog Tipicamente). Non si va più a cena al ristorante ma “a vivere un’esperienza”. Di questa esperienza siamo poco attori, piuttosto pubblico pagante, e di uno spettacolo non si sceglie il copione. Una volta letta la locandina o la recensione si compra il biglietto e si entra in teatro a godersi la performance. E se tutto questo è comprensibile nel contesto degli chef ai vertici del mondo – quasi tutti noi quando prendiamo un aereo per andare a provare un ristorante, che sia di Romito, Redzepi, Berasategui o Gagnaire, desideriamo lasciarci andare a scoprire percorsi nuovi e articolati – appare discutibile, invece, per i tantissimi ristoranti di buon livello che abbiamo: non si può pensare che virino tutti verso una proposta guidata e obbligata. Le occasioni per andare a cena fuori sono molteplici, gli stati d’animo e la compagnia anche, e non sempre si ha voglia di “fare un’esperienza”. Spesso si ha voglia semplicemente di mangiare bene, di essere accolti meglio e poter costruire la propria idea di pasto. D’altro canto l’origine della parola ristorante deriva da ristoro, non teatro, e questo ristoro dovrebbe rimanere la bussola di fondo. È vero, qualcuno, soprattutto negli ultimi tempi, ha cercato di percorrere nuove strade affiancando al concetto di menu una serie di (presunte) libertà di scelta del commensale: “Può scegliere gli ingredienti che preferisce e da questi costruiremo il percorso”. Oppure “Ci dica cosa non le piace, e lo chef immaginerà un pasto ad hoc per lei”. Ma tutto appare un po’ forzato: gli ingredienti talvolta divengono complementari e non centrali (ad esempio il radicchio scelto che diventa semplice accompagnamento di una carne) e quello che non piace diventa la bussola, quando invece si vorrebbe semplicemente scegliere ciò che piace. Lo chef, insomma, si dimentica spesso del proprio cliente e appare più interessato a mostrare ciò che sa fare e a farsi seguire nei suoi ragionamenti.
Da questo scollamento di una parte del fine dining dalle esigenze dei clienti sono nate forme nuove di ristorazione. Si tratta spesso di locali più semplici, ma non per questo di livello più basso, anzi. Basti pensare ai bistrot e a tutti quei locali senza fronzoli che oggi propongono una cucina d’autore che non ha nulla da invidiare a quella dei locali più blasonati. Sono storie che si stanno facendo strada nella critica e nel pubblico, che talvolta intrecciano la tradizione e in altri casi sono veicolo di creatività. Le storie dei locali di successo di cui su queste pagine abbiamo più volte parlato: quella di Gianni Dezio o di Diego Rossi, di Epiro o del Ratanà, de La Madia, di Mezza Pagnotta o di Reis, solo per fare qualche nome. Stanno velocemente cambiando il volto della ristorazione di qualità, indipendentemente dal format, attraverso una nuova convivialità. Perché il tema vero è che nella relazione fra chi prepara e chi mangia, fra il consumatore e la tavola, fra noi e il nostro cibo, prende forma il senso dell’esperienza gastronomica. E non è un caso che questi siano i locali più ricercati anche da molti chef stellati che, quando chiedono un consiglio su dove andare a mangiare, spesso vogliono semplicità. Sono loro, nel libro “Where Chefs Eat” ad aver compilato liste zeppe delle loro osterie e trattorie preferite. “Ma come”, verrebbe da dire, “proprio voi quando uscite a cena scansate i vostri simili?”. E allora ecco il cortocircuito, forse più evidente in una fase post-pandemica in cui cambiano valori e priorità: siamo tutti alla ricerca di semplicità e concretezza, ci riappropriamo di spazi e relazioni che avevamo perso o sottovalutato. La richiesta di cucina di qualità, di creatività, di evoluzione e sostenibilità ha aumentato notevolmente la sua platea. Ma proprio per questo la proposta ristorativa di alto livello non può parlare una lingua sola. Di questo parla la nostra necessità di scegliere, anche i piatti dal menu: forse è venuto il momento di riprendere contatto con i bisogni del pubblico, prima che sia troppo tardi.